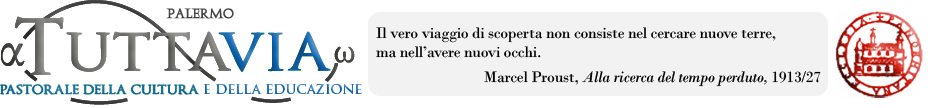
L’Amoris Laetitia, la coscienza e l’ombra di Nietzsche
di Luciano Sesta
Da quando è stata pubblicata, l’esortazione apostolica Amoris Laetitia (AL) non ha smesso di animare vivaci controversie e interpretazioni contrastanti. A grandi linee, il dibattito a cui stiamo assistendo, come del resto era già accaduto durante il Sinodo dei Vescovi, vede contrapposti due schieramenti. Potremmo chiamarli, per comodità, gli “amici della coscienza”, da un lato, e gli “amici della norma”, dall’altro lato. I primi denunciano il carattere rigido, astratto e opprimente che, nella Chiesa, ha spesso assunto la morale sessuale e familiare, presentata come un “pacchetto” di norme oggettive che attendono solo di essere applicate, pena il ritrovarsi in una situazione di peccato che tiene fuori della grazia di Dio. I secondi, al contrario, ritengono che l’insistenza sull’autonomia della coscienza dei fedeli nasconda un vero e proprio sovvertimento della morale cattolica, finendo per alimentare un clima di confusione in cui non è più chiara la differenza fra il peccato e la corrispondenza alla grazia.
La mia idea è che l’AL abbia voluto valorizzare la parte di verità che è contenuta in entrambe le letture, anche se, nel farlo, sembra sbilanciarsi sul lato della coscienza personale a spese della norma oggettiva. Si tratta però di un’illusione ottica, dovuta al fatto che il magistero dei pontefici precedenti, al contrario, sembra aver enfatizzato più l’universalità del principio che la particolarità della situazione in cui esso dev’essere applicato.
Contrariamente a quanto sostengono alcuni, si può dunque collocare AL su una linea di sostanziale continuità con l’insegnamento tradizionale della Chiesa, la quale, essendo un organismo vivo e non una pietra, rimane se stessa soltanto cambiando. Del resto, a Pentecoste, Gesù stesso aveva dichiarato di avere ancora «molte cose» da dire, di cui i suoi non sarebbero stati però «capaci di portare il peso», e che, dunque, sarebbero state rivelate solo gradualmente, sotto l’azione dello Spirito e delle circostanze storiche in cui avrebbero via via vissuto i destinatari del suo messaggio (Gv 16, 12-13). Non c’è da scandalizzarsi, dunque, se nella Chiesa le cose cambiano. Come però spesso accade in questi casi, c’è chi enfatizza la continuità e chi, invece, accentua l’effetto di rottura. Ciò risulta particolarmente evidente a proposito di quello che sembra essere, dell’AL, il nodo concettuale decisivo, ossia il rapporto fra la coscienza personale e la norma morale insegnata dal magistero.
Vorrei, a tal proposito, abbozzare la seguente ipotesi. L’idea che un cattolico possa, in coscienza, ritenere che Dio gli stia chiedendo di fare ciò che il magistero della Chiesa considera contrario alla stessa volontà di Dio, si basa su un triplice fraintendimento. Il primo, più in generale, riguarda lo stesso rapporto fra la coscienza e la norma morale. Il secondo, più specifico, riguarda il rapporto fra la coscienza del credente e il magistero ecclesiastico; il terzo, infine, il concetto stesso di misericordia divina nel suo rapporto con l’azione pastorale della Chiesa. In questo articolo tratterò il primo aspetto, riservando alle prossime uscite di “Tuttavia” la trattazione del secondo e del terzo aspetto.
Nell’invitare la Chiesa “a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle” (n. 37), papa Francesco dà per scontata un’unità di intenti fra i pastori e i fedeli. Se i fedeli non avessero le stesse preoccupazioni dei pastori e non ne riconoscessero l’autorità, in effetti, non avrebbe alcun senso lasciare che essi formino le loro coscienze. D’altra parte, i pastori sono chiamati a formare la coscienza dei fedeli non già suggerendo cosa fare materialmente nelle diverse circostanze della vita, ma aiutandoli a maturare un criterio di giudizio affinché essi prendano le loro decisioni in piena autonomia.
Il principale fraintendimento si verifica proprio a proposito di questa “autonomia”, e dipende, probabilmente, dalla natura stessa della coscienza, che, pur non essendo il “fondamento” dell’ordine morale – nel senso che non siamo noi a decidere cosa è bene o cosa è male – si presenta però come “norma prossima” dell’agire – nel senso che solo noi, e nessun altro al nostro posto, possiamo assumerci la responsabilità delle nostre scelte, buone o cattive che siano. La norma di non commettere adulterio, per esempio, pur essendo oggettiva, non può avere alcun significato morale fino a quando colui che deve osservarla non si è sinceramente convinto della sua bontà. Si può agire moralmente, in altri termini, solo quando ciò che è bene in sé lo diventa anche per me.
Ora, però, dal fatto che sia necessario convincersi, in coscienza, della bontà di una norma per poterla osservare, si deduce erroneamente che la coscienza possa anche decidere che in determinate circostanze la medesima norma può non essere valida, perché troppo astratta e generica, o, comunque, non adeguata al grado di consapevolezza, alla capacità morale o alla situazione esistenziale di colui che dovrebbe osservarla. Ciò varrebbe soprattutto per determinate norme che riguardano la morale familiare e sessuale, in cui ciò che la Chiesa ritiene che si debba sempre evitare, risulta, in determinate circostanze, come qualcosa di soggettivamente inevitabile. Si potrebbe notare, tuttavia, che poiché ad impossibilia nemo tenetur, appellarsi alla coscienza del singolo, in questo caso, è superfluo. Se osservare un determinato precetto è impossibile, infatti, non può esserci più alcun impegno della coscienza per capire come lo si può applicare nel qui e ora della propria situazione personale. Tutto avviene come se, dopo aver privato il soggetto di ogni sostegno soprannaturale che possa aiutarlo a vivere pienamente il Vangelo, glielo si restituisse nei termini di una sottile capacità di discernere, in coscienza, ciò che esattamente Dio gli sta chiedendo nella particolarità della sua situazione. Nietzsche ci aveva insegnato a diffidare della coscienza. Alcune ricorrenti interpretazioni di AL sembrano averne dimenticato la lezione, trasformando la coscienza, che è una facoltà di giudizio comunque esposta a condizionamenti e ad errori, in un infallibile oracolo.
Nonostante ogni dichiarazione contraria, questa infallibilità attribuita alla coscienza implica che la norma morale divenga del tutto superflua. Se così non fosse, il riferimento al discernimento responsabile della coscienza del singolo dovrebbe riguardare qualsiasi norma, e non soltanto, per esempio, quelle che si riferiscono alla paternità responsabile o alle nuove unioni dopo matrimoni canonicamente validi. E invece non è così. Ci si guarda bene, per esempio, dal fare della corruzione o dell’aborto una questione di coscienza. A chi, per esempio, sostenesse che, dopo lunga e meditata ponderazione, è giunto alla decisione che tradire il proprio coniuge può essere in coscienza lecito, si risponderà cercando di convincerlo che egli si sbaglia. Qualora, invece, gli si dicesse che se egli ha operato un attento discernimento cristiano può allora procedere, si ammetterebbe che non esiste alcun dovere di fedeltà coniugale. Viene il sospetto, in tal senso, che alcuni si appellino alla coscienza per “aggirare” materialmente un insegnamento della Chiesa che, al tempo stesso, non si sentono di contraddire apertamente.
Ciò avviene frequentemente a proposito dell’insegnamento di Humanae Vitae sulla paternità responsabile. Si dice, infatti, che i coniugi possono decidere in coscienza, davanti a Dio, di contraddire l’indicazione del magistero ecclesiastico, senza che ciò costituisca formalmente un “peccato”. Secondo alcuni interpreti, anche AL confermerebbe questo assunto. In realtà, a proposito di procreazione responsabile, nel n. 222 – come del resto già in Humanae Vitae, puntualmente citata da Papa Francesco – l’appello alla coscienza degli sposi riguarda la decisione se limitare o non limitare le nascite, non quella del metodo, naturale o artificiale, a cui gli sposi eventualmente ricorrono. Non è dunque in discussione il giudizio negativo del magistero sulla contraccezione, mai ritrattato da papa Francesco. Si può certamente contestare un simile giudizio, e affermare, per esempio, che la contraccezione artificiale è tanto legittima quanto i metodi naturali. Ma non si dovrebbe far dire al papa o al magistero ciò che essi non dicono. Farlo, peraltro, tradisce una mancanza di fiducia in quella stessa coscienza soggettiva di cui si celebra il potere di discernimento. Se ciò che conta, in ultima analisi, è la coscienza dei singoli al di là delle norme esplicitamente insegnate dal magistero, perché preoccuparsi di far dire anche al Papa ciò che la propria coscienza ha già deciso davanti a Dio (e contro il magistero)?
In realtà appellarsi alla coscienza ha un senso quando si tratta di valutare il modo migliore di compiere il bene, non quando si tratta di capire se ciò che sappiamo essere un male può non esserlo più. Bisogna precisare, a questo riguardo, che nell’attuale dibattito si dimentica spesso che, nella dottrina morale della Chiesa, si distingue con cura fra norme positive, che prescrivono determinate azioni il cui compimento deve tenere conto dell’opportunità del contesto e della situazione soggettiva di chi agisce, e norme negative che, a differenza delle prime, proibiscono sempre il compimento di azioni per se stesse incompatibili con l’ideale di vita proposto nel Vangelo. Queste norme negative, alcune delle quali sono indicate nel Decalogo, sono poche ma fondamentali, perché rappresentano l’identità del cristiano, che è sempre un uomo disposto a tanto ma non a tutto. Un uomo, dunque, capace di dire alcuni pochi ma decisivi “no”, da cui dipende il suo essere “segno di contraddizione” rispetto a quello stesso mondo in cui è chiamato a testimoniare una Luce che proviene da altrove.
La Chiesa, di conseguenza, afferma che le norme che non si devono “mai disattendere né trascurare” (AL 304) non sono quelle positive che prescrivono un bene, ma quelle negative che vietano di compiere un male, e, in particolare, quelle che si riferiscono ai cosiddetti “atti intrinsecamente cattivi” (intrinsece mala). Possiamo sempre tralasciare un bene per un bene più urgente. Ma non possiamo compiere un male per ottenere un bene. Potrei, per esempio, trascurare la salute per salvare la vita di una persona, ma non posso, se sono sposato, accettare di fare l’amore con una donna solo perché lei minaccia di uccidersi se io mi rifiuto. Rispetto a queste norme, dunque, non c’è buona intenzione o circostanza che possa modificarle, rendendo “buono” o “lecito” ciò che è in sé sbagliato. Diversamente dalle norme positive, che prescrivono di fare il bene, le norme che vietano il male non sono oggetto di “discernimento” alla luce delle situazioni particolari.
Il discernimento, in effetti, non è finalizzato a capire come un’azione di per sé cattiva possa, in determinate circostanze, diventare buona, ma quale sia, fra le diverse possibilità di bene, quella che siamo chiamati a realizzare nel qui e ora di una situazione specifica o nell’intero corso dell’esistenza, come quando si parla di “discernimento vocazionale”. La classica domanda del discernimento, in tal senso, è qualcosa del tipo: “Cosa vuole realmente Dio da me in questo momento?”. Alcune interpretazioni di AL, invece, sembrano sostituirla con la domanda: “A quali condizioni ciò che la Chiesa ritiene peccato può non esserlo?”. In questo, però, si scontrano con numerose precisazioni in cui papa Francesco esclude che la comprensione delle situazioni particolari possa indurre a ridimensionare la chiamata alla santità rivolta a ciascun credente: «Comprendere le situazioni eccezionali non implica mai nascondere la luce dell’ideale più pieno né proporre meno di quanto Gesù offre all’essere umano» (AL 307).
Per una persona che non riesce a uscire da una condotta abituale di peccato, dunque, il discernimento non è finalizzato a capire se il proprio stato di vita è conforme al Vangelo, ma se Dio gli sta chiedendo di accettarlo come un limite che, in quel momento, non gli è dato di superare. In questi casi il fedele non intende giustificarsi, ma solo prendere atto che sul momento non può abbandonare una determinata situazione se non al prezzo di ulteriori mancanze e sofferenze. E non è escluso che Dio, in quel momento, gli stia chiedendo proprio di “tollerare” una simile situazione come una forma di testimonianza genuinamente cristiana, senza accanirsi contro i propri limiti in nome di una perfezione ideale.
L’intuizione profonda di AL, a questo riguardo,è che le persone coinvolte in situazioni oggettivamente difformi dalla volontà di Dio potrebbero trovarsi soggettivamente unite a Lui più di quanto non si trovino coloro che, pur vivendo in situazioni “regolari”, mostrano l’atteggiamento farisaico di chi si crede a posto agli occhi di Dio. E questo è possibile, tuttavia, solo se ci si appella alla propria “coscienza” non per giustificarsi, ma, semmai, per accusarsi. Se infatti ci si appellasse alla coscienza per considerare la propria condizione talmente “particolare” da sottrarsi, momentaneamente o stabilmente, a determinate esigenze della vocazione cristiana, ci si troverebbe nella medesima situazione di chi, pur vivendo in una condizione oggettivamente gradita a Dio, finisce per allontanarsi da Lui proprio perché crede di essere senza difetto ai Suoi occhi. Lungi dal lodare il fariseo che si crede a posto – figura con cui rischia sempre di identificarsi il cattolico che riceve abitualmente l’eucaristia – Gesù ha parole di lode nei confronti del pubblicano che, in fondo al tempio, si batte il petto perché non si ritiene degno di stare al cospetto di Dio.
Ecco allora il limite di tutte le interpretazioni dell’AL che insistono sulla “coscienza personale” al fine di scardinare le norme “oggettive”: tutto avviene come se l’atteggiamento misericordioso che dovrebbe provenire da Dio procedesse invece dalla propria coscienza, non distinguendosi più, in tal modo, dall’autoindulgenza. E, come sappiamo anche dal Vangelo, lungi dal costituire un primo barlume di misericordia divina, l’autoindulgenza diventa il suo più grande ostacolo. Non si tratta di affermare che il perdono e la misericordia divina non potrebbero essere elargiti se non a condizione che la coscienza mostri un pentimento esplicito. È vero, infatti, che il Vangelo ci ha insegnato il contrario, ovvero che è solo il perdono anticipato di Dio a suscitare, nel cuore umano, la conversione e il pentimento, come probabilmente è accaduto all’adultera, perdonata da Gesù ben prima di avanzare una formale richiesta di perdono. Ma, appunto, qui l’esperienza della misericordia può risuonare nella coscienza di chi la riceve non certo perché egli se la attribuisce in anticipo con il proprio discernimento, ma perché viene da altrove come qualcosa di inseparabile dall’esigenza di rinnovare il cuore e la mente, ovvero di agire in direzione contraria a quella che ha motivato il perdono.
E qui va fatta un’ulteriore osservazione. Quando papa Francesco scrive che «la legge rende consapevoli dell’obiettivo cercato, anche se quello stesso obiettivo non è ancora raggiunto», c’è il rischio di interpretare la vita cristiana come una “prestazione morale” del credente, piuttosto che come un rapporto personale con un Dio che salva. Insistere sull’ideale “oggettivo” contrapposto alla situazione “soggettiva”, in effetti, può indurre a guardare con indulgenza la situazione soggettiva solo perché rimane fermo il presupposto, decisamente moralistico, che l’ideale oggettivo debba in ogni caso essere raggiunto. Se invece l’ideale oggettivo, più che esito di uno sforzo morale, è concepito come pienezza ricevuta in dono, allora il suo mancato raggiungimento non ha più il carattere di un difetto morale da comprendere e da scusare, esprimendo piuttosto un limite umano che riguarda tutti gli uomini, e dunque anche coloro che, apparentemente, vivono secondo l’ideale oggettivo. Tutti gli uomini, infatti, ricevono da Dio ciò che rende “regolare” la loro condizione morale. E se alcuni corrispondono più di altri al dono, ciò non accade perché sono migliori, visto che essi potrebbero non aver vissuto i problemi che hanno vissuto gli altri. La diversità delle risposte alla grazia, in tal senso, non si spiega solo appellandosi alla libertà umana. Sarebbe così solo se tutti gli uomini, in pari condizioni di partenza e nelle medesime circostanze psicologiche, sociali, culturali, economiche ecc., si trovassero di fronte alla medesima proposta di grazia.
C’è dunque una “legge della gradualità” non solo per chi, in positivo, si impegna nella via di un bene che è chiamato a vivere in pienezza, ma anche per chi, in negativo, è ancora alle prese con il dovere di astenersi dal male. Chi, abitualmente, vive in una condizione difforme dall’ideale evangelico, e cioè chi si trova nella famosa “situazione irregolare”, non sempre può abbandonarla subito e totalmente, soprattutto quando vi sono in gioco altri valori, come l’accudimento di figli nati dalla nuova unione. Da questo punto di vista anche in ordine al male, non solo in ordine al bene, non a tutti è chiesto sempre e in ogni momento lo stesso comportamento. Ciò che si richiede, in queste situazioni, è una tensione verso l’ideale che non si traduce, necessariamente, nel tentativo costante e, talvolta, logorante, di “rettificare” la situazione, ma anche nell’umile accettazione dei propri limiti, a cui può unirsi l’intima consapevolezza che Dio, in quel momento, non sta chiedendo una prestazione morale eroica che non si è in grado di offrirgli, ma solo il riconoscimento della propria povertà. Non è escluso, infatti, che con tutto l’impegno possibile, non si giunga alla fine all’esito sperato, come per esempio accade a una persona omosessuale che per anni ha provato a “rieducare” il proprio desiderio senza riuscirci, o a una coppia di divorziati risposati che non riescono a ricostruire il precedente matrimonio canonicamente valido.
Qualora si volessero “normalizzare” le situazioni descritte, attribuendo alla coscienza degli interessati il “potere” di sancire la compatibilità fra la loro situazione e la volontà di Dio, si finirebbe, paradossalmente, per sopravvalutare l’importanza delle “opere” della legge e per assumere una visione moralistica dell’esperienza cristiana. Cosa può indurre infatti a dire che un comportamento che per la legge è “peccato” è, in foro interno, qualcosa da cui Dio sta dispensando, se non il desiderio di evitare che il credente rimanga in difetto nei confronti della legge? In questo modo l’amico della coscienza cade nello stesso moralismo che egli rimprovera all’amico della norma. Anche lui, come il suo interlocutore, non può sopportare che il cristiano rimanga in difetto nei confronti della legge, ed è per questo che cerca di esorcizzarla definendola “astratta” e inapplicabile alle situazioni “concrete”.
L’insegnamento tradizionale della Chiesa sui rapporti fra fede e morale si colloca al di là di questa alternativa. Fra la pretesa di applicare sempre la legge morale (amici della norma) e quella di sospenderne la validità in determinate circostanze (amici della coscienza), c’è infatti una terza via, che consiste nell’affermare che l’uomo giusto non è né colui che si sforza di raggiungere moralmente una vetta ideale, né colui che, non riuscendoci, ritiene in coscienza di non essere chiamato a farlo. In entrambi i casi, infatti, l’uomo fa tutto da sé, senza mai veramente confidare nella misericordia di Dio. Ridimensionare l’importanza delle opere alla luce della grazia, allora, non significa ritenersi in coscienza esonerato dall’osservarle, ma accettare con serenità di non riuscirci, nella consapevolezza che a lavorare, in ultima istanza, non siamo noi, ma lo Spirito [continua].

